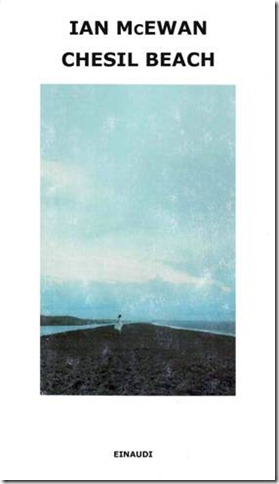Il momento che stiamo vivendo è bruttissimo non solo per la cattiva situazione economica che c’è in molti paesi del mondo, compreso il nostro, ma anche per le terribili guerre che si stanno combattendo non lontano da noi. I morti e i feriti nei combattimenti ormai non si contano più e non fanno più nemmeno notizia sui giornali o sui telegiornali. Se potessi, con una bacchetta magica, farli terminare non ci penserei nemmeno un istante. Vivere in pace sul nostro martoriato pianeta è un’utopia che i signori della guerra disdegnano a priori. Eppure la pace, a parole, la sostengono tutti…
Per distogliere dalla mente questi tristi pensieri, faccio ricorso a un breve capitolo del primo libro che ho scritto parecchi anni fa ricordando una guerra particolare e abbastanza cruenta, ma senza morti e feriti, a cui ho assistito quand’ero bambino.
Buona lettura.
Nicola
La guerra del latte
L’estate del 1952 si presentava, in modo non difforme da tutte quelle precedenti, calda, stupendamente oziosa, inframmezzata dai soliti lavoretti fatti giusto per non dispiacere ai nonni che lo ospitavano nella masseria a Incoronata in Puglia.
I nonni confidavano molto in Nicola e nella sua capacità di affrontare con grinta la vita. Spettava a lui, in un futuro non lontano, portare la famiglia a un livello sociale più elevato e questo lo obbligava, quasi sempre, a comportarsi in modo da non deludere le loro aspettative.
Per nonno Pietro, Nicola da subito era diventato “il nostro ometto”.
Una simile definizione, se da un lato soddisfaceva la parte più profonda del suo io infantile, dall’altro, gli andava stretta e insopportabile proprio per la responsabilità che essa comportava. Lui avrebbe preferito mille volte di più potersi abbandonare a quelle gratificanti marachelle che sono il vero pane dei bambini della sua età.
Nonostante avesse solo dieci anni, Nicola aveva capito che conveniva dare ai nonni e ai genitori un’immagine di sé il più possibile rassicurante e matura: ciò faceva distogliere il loro sguardo vigile dalla sua persona quel tanto da permettergli un certo margine di manovra. In quei momenti di distrazione familiare, rari in verità, dava il meglio di sé e riusciva a godere di tutte le opportunità che la libertà e la sua fantasia gli offrivano.
Proprio in quei momenti nascevano le “azioni avventurose” più belle.
Con tale espressione, lui e il cugino Pietro, indicavano quei comportamenti che, una volta scoperti, avrebbero avuto ben altri appellativi e sarebbero stati salutati a scapaccioni e non certo a battimani.
Una di queste azioni, rimasta negli annali della famiglia Losito, fu la cosiddetta “guerra del latte”.
Ogni estate, alla masseria si riuniva una folla di parenti provenienti da diverse città d’Italia. I nonni Palmieri avevano generato sette figli e questi, sposandosi, si erano sparpagliati per tutta la penisola. La loro grande casa e le lunghe vacanze scolastiche erano il luogo e l’occasione adatti a riunirne buona parte. Nell’e¬state del ‘52 il lungo tavolo di cucina ospitava almeno venti persone tra adulti e bambini.
Fra questi c’era Pietro, il carissimo cugino di Roma.
Dopo pranzo, il nonno faceva sempre un breve pisolino seduto scomodamente sulla stessa sedia utilizzata poc’anzi per il pasto. La nonna e le donne di casa, figlie e nuore, rassettavano la cucina chiacchierando fra di loro a bassa voce per non disturbarlo. I bambini, se lo desideravano, potevano salire in camera per dormire o leggere.
In campagna non c’erano altre alternative. La temperatura esterna sconsigliava azioni più impegnative. Lui e il cugino Pietro, però, quel giorno non avevano sonno. I giornalini a disposizione erano stati letti e riletti più volte, per cui entrambi vagolavano annoiati per la cucina. Col proposito di fare qualcosa di diverso dall’ascoltare le chiacchiere delle donne, presero il corridoio che, attraverso l’atrio adibito ad attrezzeria, portava alla stalla. Anche qui, con i due cavalli da una parte e le sei mucche dall’altra, si respirava la stessa atmosfera oziosa del dopo pranzo.
Che inventare allora?
Saliti in groppa a Luna e Fiorello, da quell’alta e privilegiata posizione presero a imitare sfrenate cariche della cavalleria contro orde di indiani cattivissimi e dal volto variamente dipinto. A un certo punto, buttando l’occhio dall’altro lato della stalla e vedendo le enormi e gonfie mammelle delle mucche che ruminavano tranquille, a Nicola venne un’idea.
La comunicò al cugino e lui l’approvò immediatamente.
Fu così che i due bambini, afferrate per i capezzoli le mammelle delle due mucche più distanti e spremendole con forza diedero vita, con mirati spruzzi di latte, a una fantastica e combattutissima battaglia. Le mucche, per un po’ li lasciarono fare, poi cominciarono a dare segni evidenti di insofferenza, muggendo e scalciando nel contempo.
Era quello il momento di sospendere le ostilità e porre fine alla guerra.
La battaglia aveva però lasciato visibili macchie sui loro pantaloncini e magliette, macchie che, asciugandosi, si erano trasformate in striature giallastre accompagnate da un acre odore di latte, molto fastidioso all’olfatto. Fu questa la ragione per cui il ritorno in cucina dei due guerrieri non venne accolto con acclamazioni e applausi?
Parrebbe di sì. Il forte olezzo che viaggiava insieme a loro e la situazione disastrosa dei loro indumenti, trasformarono immediatamente l’esito della gloriosa tenzone in una storica disfatta. Mamme e nonni ci misero ben poco a capire cosa i due cugini avevano combinato nella stalla.
Nicola, rincorso da sua madre, si prese subito due solenni sculaccioni e una memorabile tirata d’orecchie. Pietro, prima che la sua potesse afferrarlo per affibbiargli la meritata punizione, fu raggiunto dal bastone che il nonno teneva sempre a portata di mano.
A quel punto successe il finimondo.
Mentre i due bambini piangevano a voce spiegata, la mamma di Pietro, offesa perché a punire il figlio fosse stato il suocero e non lei, iniziò a litigare con la madre di Nicola, colpevolizzandola per non essere mai stata capace in vita sua di bloccare in tempo le malefatte del figlio. Lei, per difendersi, contrattaccò facendo l’elenco delle cose orribili commesse da Pietro sin dal giorno della nascita. I nonni, nel tentativo di frenarle, difendendo ora uno ora l’altro dei nipoti, non fecero che provocare un ulteriore inasprimento della lite che proseguì furiosa per un paio d’ore.
Nessuno, nel frattempo, sembrava più interessarsi di Nicola e Pietro che, archiviato il pianto, si guardarono negli occhi e con gesti del capo e della mano si accordarono per salire in camera da letto e allontanarsi in fretta da un campo di battaglia diventato molto più pericoloso di quello affrontato prima nella stalla.
La guerra del latte si era rovinosamente trasformata nella ”guerra delle zie”, una battaglia così aspra e astiosa da lasciare tra le due donne strascichi e malumori mai interamente sopiti anche dopo anni di successive frequentazioni.
I due cugini, invece, amici per la pelle, nel giro di cinque minuti avevano dimenticato la punizione ricevuta. Dalla camera da letto situata proprio sopra la cucina, se la godettero un mondo nel sentire le loro madri mentre si beccavano in modo così acceso, impegnate, col procedere dello scontro, più nella strenua difesa della bontà e intelligenza del proprio figlio, che nello scusarsi del comportamento incosciente e birichino di entrambi.
Alla masseria una vera pace tornò solo al momento della partenza di Pietro per una nuova destinazione, una settimana dopo. La sua famiglia non si fermava mai per più di un mese in campagna: la loro vacanza, in agosto, proseguiva al lago di Lesina presso i nonni materni. Doversi lasciare così presto, per i due cugini era un grosso dispiacere: in barba alla nota insofferenza fra le rispettive madri, loro due si volevano un bene dell’anima. Il distacco era condito, come sempre, da lucciconi agli occhi. Per Nicola, in assenza del cugino, le “azioni avventurose” ancora possibili in quell’estate che stava volgendo al termine, sarebbero state purtroppo monche di un protagonista attivo ed efficiente.
Mio cugino, in seguito, intraprese la carriera militare in aeronautica, raggiungendo, alla fine, il grado di colonnello. Io, invece, mi laureai in ingegneria elettronica.
Da pensionati, di tanto in tanto, ci incontriamo e, come tutti i vecchi di questo mondo, spesso ricordiamo i bei tempi della nostra adolescenza.
Ci credereste?
Pietro non ha ancora dimenticato il colpo di bastone ricevuto, quella volta, dal nonno e a me provoca ancora sofferenza l’umiliante sculacciata infertami da mia madre di fronte a tutta la parentela.
Se lo incontraste e vi capitasse di parlare con lui della famosa “guerra del latte”, non dategli assolutamente retta.
Quel giorno, la battaglia con le mammelle delle mucche l’ho vinta io.
Giuro.